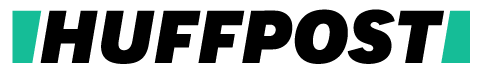Adapt – Motivo oggettivo e repêchage. L’evoluzione (incompiuta) della giurisprudenza di Federico Avanzi
Il contratto di lavoro subordinato rappresenta, ancora oggi, uno dei “teatri” prediletti dalla giurisprudenza per esibire, sovente in necessaria supplenza del legislatore, la propria incisività nonché, talvolta, “teleologica” creatività, in termini di diritto effettivo. In particolare, questo risulta evidente se si osserva il perpetuo quanto dinamico “abbraccio” esegetico della magistratura, alla normativa di riferimento in materia di licenziamenti individuali.
Invero, accanto a un, già di per sé, articolato quadro regolatorio di controllo sull’esercizio del potere di recesso, realizzato individuando, con l’art. 2119 c.c. e l’art. 3 L. n. 604 del 1966, presupposti giustificativi mediante una clausola generale (giusta causa) e una norma generale (giustificato motivo soggettivo e oggettivo) che delineano “fattispecie” ampie (così, C. Zoli, in WP CSDLE M. D’Antona n. 428-2020, Il puzzle dei licenziamenti ed il bilanciamento dei valori tra tecniche di controllo e strumenti di tutela, p. 3) a disciplina – rectius tutela – tripartita (art. 8 L. 604/1966, art. 18 L. 300/1970 e D.L.gs. 23/2015), la giurisprudenza non ha certo fatto mancare la propria opera, non solo di interpretazione, ma anche di “arricchimento” del dato testuale normativo.
Focalizzandosi sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il contemperamento – ponderatamente sbilanciato – tra i valori di tutela del posto di lavoro e della libertà d’impresa, ha prodotto, nel tempo, una vera e propria manipolazione, de facto, della originaria ragione giustificatrice di cui all’art. 3 ossia tale se inerente “all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Si rifletta, a esempio, di come la fattispecie sia stata indebitamente “riempita” sino al punto di ritenere precettivamente imposto che, nel dilemma tra una migliore gestione aziendale e il recesso da un singolo rapporto di lavoro, l’imprenditore potesse optare per la seconda soluzione, solo a condizione che si trovasse a fronteggiare sfavorevoli e non contingenti situazioni di crisi.
E se tale elemento, addizionale, di legittimità al recesso, può, oggi, anche sulla scorta delle limitazioni legislative sul “sindacato di merito” (art. 30, c. 1 L. n. 183/2010), sostanzialmente dirsi obliterato (Salvo eccezioni, Cass. n. 25201/2016 e successive), non altrettanto può affermarsi per altra conditio di assoluta matrice giurisprudenziale e da assumersi, alla stregua della precedente, quale perfetta espressione di “concorrenza” alla discrezionalità del legislatore.
Si intende riferirsi al c.d. obbligo di repêchage, secondo cui il datore di lavoro ha l’incombenza di dimostrare, con riferimento all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento – e non solo (vedi infra) – anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici, la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni differenti da quelle soppresse, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio e potendo l’onere in questione, ricondursi ai generale principio della buona fede, il quale impone, a ciascun contraente, di soddisfare i propri interessi nel modo meno pregiudizievole per la controparte (sul risalente orientamento Cass. n. 20436/2016 e Cass. n. 7755 del 1998).
Dunque, oltre l’effettività e non pretestuosità della soppressione del posto riferibile al lavoratore, quale conseguenza – e non causa – di ragioni organizzative ammesse per giurisprudenza costante (Cass. n. 13516/2016), il datore recedente deve provare, altresì, di non aver posizioni lavorative scoperte, poiché stabilmente occupate, oltreché, per un congruo periodo dopo il licenziamento, di non procedere a nuove assunzioni (Cass. n. 12101/2016), senza che gli sia consentito eccepire limiti territoriali nella “ricerca” e potendo esclusivamente addurre l’estremo di una, comunque, proficua (ri)utilizzabilità del prestatore nell’impresa, ad assetto organizzativo inalterato (Cass. n. 16141/2002).
Allegazione e prova – negativa – che non gravano sul lavoratore estromesso, nemmeno in termini cooperazione (Cass. n. 12101/2016), poiché spettanti al titolare del rapporto, il quale potrà anche fruire delle opportunità offertegli dalla “vicinanza” della prova, essendo lui il detentore delle scritture aziendali, es. Libro Unico del Lavoro e, peraltro, senza che possa reputarsi sufficiente, di per sé sola, ai fini dell’integrale adempimento, una estemporanea, se non addirittura fraudolenta, “proposta” di assegnazione alternativa, effettuata dal medesimo, in epoca precedente il recesso (sulla insufficienza della “proposta”, Cass. n. 9869/2017).
Incombenza di rilevo, anche osservando i “contenuti” delle mansioni vacanti da vagliare, assunto come l’indagine datoriale di “compatibilità” con il concreto contenuto professionale (Cass. n. 21579/2008) del lavoratore, c.d. equivalenza sostanziale, sembra, oggi, superata, ope legis, in favore di un concetto “dinamico” di professionalità (Trib. Milano n. 2137/2017), c.d. equivalenza formale (su questo concetto si rimanda a F. Avanzi, Diritto e tutela della professionalità. Riflessioni sull’art. 2103 c.c. e questioni di compatibilità con i principi costituzionali, in Bollettino ADAPT n. 39/2019) che per di più positivizza, “in verticale discendente” (c. da 2 a 5 art. 2103 c.c.), l’adempimento della ricollocazione, determinando, nei fatti, un sostanziale aggravamento, anche in ordine probatorio, dell’obbligo di repêchage (per un caso concreto, Trib. Torino n. 1676/2019).
Pertanto, anche se ciò non arriva a costituire “fatto” autonomo rispetto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive determinanti la soppressione d’un dato posto di lavoro, tale da richiedere una specifica e indipendente contestazione da parte del lavoratore, il “ripescaggio” rappresenta, comunque, uno dei due aspetti del medesimo “fatto” estintivo – il giustificato motivo oggettivo – fra loro inscindibili, poiché l’uno, senza l’altro, inidoneo a rendere valido il recesso (Cass. n. 12101/2016).
Dunque, esegesi di assoluta rilevanza tecnico-giuridica, non solo perché attribuirgli i “gradi” di “elemento costitutivo” della fattispecie, significa, in sostanza, azzerare la discussione su chi incomba l’onere della prova, ma anche, e soprattutto, perché ciò determina notevoli riflessi in termini di protezione riconosciuta al lavoratore.
In particolare, per i lavoratori soggettati all’art. 18 legge 300 del 1970, una volta accertata l’ingiustificatezza del licenziamento per carenza di uno dei due presupposti e, in particolare, perciò che qui rileva, per inottemperanza all’obbligo di repêchage, il giudice di merito, ai fini dell’individuazione del regime sanzionatorio da applicare, dovrà procedere, salvo ipotesi di “eccessiva onerosità” per il datore, con la tutela reintegratoria attenuata (art. 18 c. 4), essendo che l’espressione lessicale utilizzata dal legislatore “manifesta insussistenza del fatto” (art. 18 c. 7), risulta sganciata da richiami diretti ed espliciti alle “ragioni” previste all’art. 3 L. n. 604 del 1966, dovendosi, dunque, ritenere il riferimento normativo effettuato alla “nozione complessiva” di giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 10435/2018).
Nondimeno una, a questo punto, così “grave” illegittimità potrà – dovrà? – pesare, probabilmente, anche nella definizione, quantitativa, degli altri sistemi di ristoro e dissuasione prettamente indennitari (art. 8 L. 604/1966, artt. 3 e 9 D.L.gs. 23/2015).
Certo, è bene ribadirlo, la magistratura dovrebbe riservare simili conseguenze, esclusivamente, qualora venga appurata una evidente e facilmente verificabile, sul piano della prova, assenza di “ripescaggio” ossia la sua “manifesta insussistenza” e non anche ai casi di mera “insufficienza probatoria” (Sulla distinzione fra “manifesta insussistenza” e “insufficienza” probatoria, Cass. n. 10435/2018 e n. 26460/2019).
Sembra poi doveroso notare come l’evoluzione interpretativa testé, tanto risalente, quanto laboriosa, risulta, comunque, parzialmente compiuta o, quantomeno, non definitiva, registrandosi anche di recente, pronunciamenti non perfettamente coincidenti al “pensiero” giurisdizionale, sistematico e di principio, sin qui, in sintesi estrema, richiamato.
Basti pensare, in questo senso, all’obbligo di motivazione (art. 2 legge 604/1966) che, secondo costante orientamento, non ricomprenderebbe affatto il repêchage.
Questo perché, secondo l’esegesi pretoria, il dovere di comunicare per iscritto i motivi del recesso, non riguarderebbe tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento, essendo invece sufficiente l’indicazione della fattispecie nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente diversa, mentre l’inutilizzabilità aliunde rappresenterebbe un elemento implicito da provare, direttamente, in giudizio (Da ultimo, Cass. n. 16795/2020).
Ora, salvo il particolarissimo caso del licenziamento, oggettivo, nel contratto di somministrazione, ove può sostenersi che, in sostanza, la mancata ricollocazione rappresenta anche la ragione organizzativa (F. Avanzi, in SINTESI, rassegna di giurisprudenza e dottrina di Febbraio 2020, Giustificato motivo oggettivo, repêchage e somministrazione. Analisi di un licenziamento individuale sui generis), se il repêchage, come già detto, risulta essere uno dei due aspetti del medesimo fatto estintivo ovvero del giustificato motivo oggettivo, non si comprende come possa dirsi legittima la sua omissione all’interno dell’atto di recesso che dovrebbe propriamente, ex lege, contenere “la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”.
Anche tale questione, concludendo, pare tutt’altro che di “lana caprina” se riflettuta nell’ottica delle specifiche “sanzioni” per violazione del requisito di motivazione, previste, puntualmente, dal nostro ordinamento (art. 18 c. 6 L. n. 300/1970, art. 4 D.L.gs. n. 23/2015).
Federico Avanzi
Consulente del lavoro
Bollettino ADAPT 1 febbraio 2021, n. 4