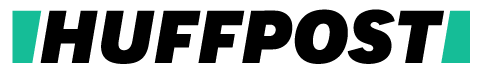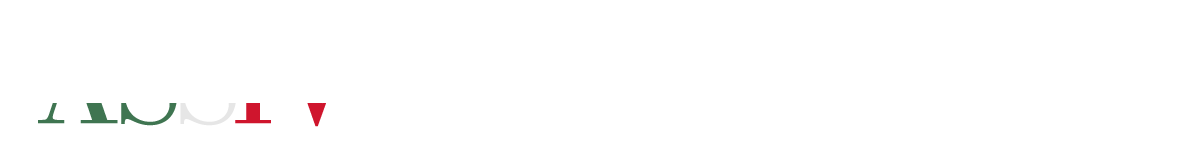Governance della vigilanza privata, quanto pesa la crisi dei corpi intermedi?
Intervista di Securindex a Maria Cristina Urbano, Presidente di ASSIV
D: Si parla da tempo di “crisi dei corpi intermedi” intesi come partiti, sindacati, associazioni e quant’altro sia concepito come tramite tra cittadini e istituzioni. Dal suo punto di osservazione qual è la situazione in generale?
R: In effetti è più di un decennio che studiosi, politici e titolati giornalisti discettano della crisi dei corpi intermedi, analizzandone le cause ed i possibili rimedi, ma il declino, a mio avviso, è sempre più palpabile, ed è il portato di un mix di fattori: il più evidente è quello della (quasi) scomparsa delle forme di aggregazione tradizionali: il circolo ricreativo e culturale, la sezione di partito, il sindacato, la parrocchia, perfino i vari “club” di discendenza anglosassone, che mischiavano l’appartenenza ad una classe sociale alle “charity missions”, sono in penosa crisi vocazionale. Quei luoghi e quei momenti aggregatori servivano non solo per sviluppare la “vita sociale”, elemento fondante dell’essere umano, ma anche e soprattutto per confrontare idee, per sviluppare progetti e porre obiettivi utili ed omogeni per soggetti aggregati. Il mio punto di vista, che è quello della presidenza di una associazione di categoria, non può che rilevare gli stessi sintomi di grande stanchezza e di una certa sfiducia nei confronti dell’efficacia delle attività poste in essere, a cui peraltro si associa una scarsissima volontà di impegno personale da parte degli associati.
D: C’è chi sostiene che tra le cause di questa caduta di interesse ci siano anche i social che permettono una relazione diretta tra le parti, diminuendo drasticamente il ruolo degli intermediari tradizionali. E’ vero?
R: E’ verissimo. La disintermediazione sociale e politica è alimentata dalla incredibile facilità di accesso ai mezzi di comunicazione. L’uso dei “social” dà al cittadino l’illusione di poter dialogare direttamente con il leader, cioè con il detentore del potere, e comunque l’espressione del proprio pensiero è libera e diretta per chiunque. Di contro, chi il potere lo detiene e lo gestisce ha effettivamente, tramite gli attuali veicoli di comunicazione, la possibilità di parlare ad ogni singolo individuo che sia “collegato”, e quindi usare questa opportunità quale formidabile strumento di persuasione, e, a volte, di manipolazione. Questo rapporto diretto ed istantaneo supera le forme tradizionali di aggregazione ed elaborazione di proposte e percorsi di negoziazione tra parti. Quella che emerge è una concezione individualista e parziale della società che tende a cercare il consenso immediato e a breve termine, senza visione prospettica e strategica . Un atteggiamento, questo, che genera a sua volta una sfiducia nelle attività dei corpi intermedi, i cui percorsi di elaborazione, proprio perché basati sulla organizzazione di aggregazioni numerose di individui, richiedono maggiori tempi di realizzazione. Inoltre, e questo non è un aspetto secondario del fenomeno, l’estrema velocità delle connessioni genera dei “botta e risposta” ad effetto, a beneficio di una divulgazione estremamente semplificata e semplicistica di situazioni e concetti complessi, che invece richiederebbero approfondimento ed argomentazione.
D: Venendo al mondo della vigilanza privata, come si delinea la situazione considerando che tanto le associazioni datoriali quanto i sindacati dei lavoratori stanno aumentando invece che diminuire per unire le forze, con problemi di rappresentatività sempre maggiori?
R: Un bel problema direi, che sconta, oltre ai fenomeni di cui sopra, anche una particolarità tipica del settore (in comune con molti altri, comunque). Per parte datoriale si assiste, ferma la giusta convinzione che un “corpo intermedio” serva per promuovere istanze ed interessi della categoria, alla personalizzazione del corpo intermedio stesso, che viene visto non come centro di aggregazione di una base omogenea ma quanto più vasta possibile, ma come schermo per promuovere istanze ed interessi di pochi se non di pochissimi stakeholder. Da qui la frammentazione. Percorso analogo può essere letto anche nella già consolidata fioritura di sigle sindacali di comodo, che guastano non poco il già arduo lavoro di composizione delle istanze contrapposte che caratterizza il rapporto fra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. A queste difficoltà si aggiungono quelle contingenti, che hanno visto l’impennata dell’inflazione e l’aumento del costo del denaro. Il primo fenomeno ha fortemente indebolito il potere di acquisto, con conseguente difficoltà dei lavoratori e diminuzione dei consumi, il secondo ha portato grandi problemi alle imprese. Il risultato è stato un impoverimento anche del confronto datori – sindacati, che si è ridotto ad unico argomento: la questione salariale, impedendo qualsiasi altro tipo di ragionamento su tutta la gamma delle possibili leve di politica aziendale. Un panorama di oggettiva difficoltà, che non aiuta il ricostituirsi di centri di aggregazione intermedi dotati di autorevolezza, sia per la pluralità delle idee che per la capacità di rappresentarle con chiarezza ed unità di intenti.
D: Ritiene sia una tendenza irreversibile o legata a fattori transitori?
A questa domanda non ho una risposta sicura. Il fatto che la nostra società stia attraversando un periodo di transizione, caratterizzato da quattro grandi sfide: la migrazione di massa, che si accompagna al nostro declino demografico, la competizione globale di mercato, il cambiamento climatico e la rivoluzione tecnologica, mi fa pensare che siamo lontani dal raggiungimento di un assetto duraturo, anche per quanto riguarda il recupero di centralità dei corpi intermedi. Penso che questi grandi temi dovrebbero ispirare forme di aggregazione anche più vaste della sola nazione, per il rilancio della cultura della mediazione e del dialogo sociale e istituzionale, che nasce dal riconoscimento di interessi omogenei e dalla capacità di farsene promotori in un ruolo di concreta sussidiarietà nei confronti dei poteri statali e sovranazionali. Per adesso però non mi pare di intravedere questa tendenza. Speriamo che i nuovi strumenti e i nuovi linguaggi che i corpi intermedi hanno a disposizione contribuiscano non solo a difendere interessi settoriali, ma anche a definire scelte politiche e sociali di più ampia visione.
Scarica l’intervista completa